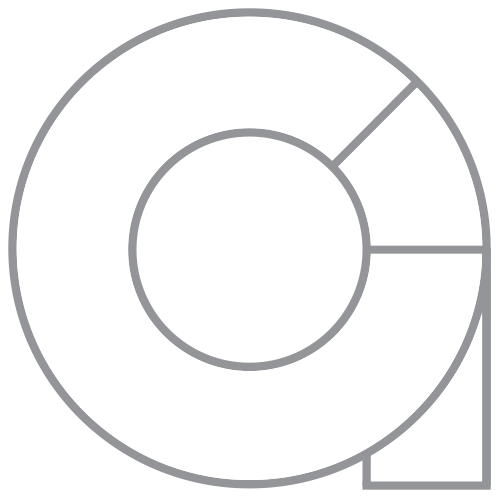Tra spettatore e superficie (Lo sposalizio della vergine), 2006
Video digitale in ripetizione, audio stereo
Cul de sac
Non c’è nulla per noi di più paradossale che proprio attraverso la paradossia non ci divenga assolutamente evidente.
Hermann Schweppenhäuser
Cul de sac, impedimento, strada senza sfondo o senza via d’uscita, divieto, pericolo, vulnus interdizione, rimozione, risacca, hapax, oscenità. Cul de sac indaga ciò che resta dell’opera che, una volta ‘costruita’, tende inevitabilmente a celare e a dimenticare il suo indecidibile processo di costruzione inteso qui come metastasi nella quale appunto la singolarità annienta l’universale. Cul de sac inteso come quella cosa che il processo stesso dimentica e rimuove in fieri proprio per ri-nascere teleologicamente. Cul de sac come un qualcosa di nuovo conficcato nella reiterazione di una riproposizione intesa come atto identico, al tempo stesso ciò che è venuto e ciò che è ancora qui, presente in ciò che è stato rovinato mediante la sua presenza celibe. Esiste infatti un nucleo indecidibile di forma-lizzazione che preme ed insiste in ogni arrivo come in ogni provenienza; immagine in-diretta, qui e ora e quindi già irreparabilmente passata attraverso il (non) ritorno del rimosso, attraverso la propria inattingibile inamovibilità. Questo scarto senza scarto non si riassume in alcun modo in una presenza o in un’assenza, in un’accettazione o in una trasgressione, esso si situa piuttosto nel punto cieco che nessuna formalizzazione riuscirà mai a formalizzare. Una formalizzazione che s’ingenera solo se l’assolutezza della sua assenza coincide con lo stesso ‘modo d’essere’ della sua presenza. Questa presenza non ricade sotto nessuna categoria dell’ente, sia essa presente o assente, essa è in qualche modo l’atto irrecuperabilmente finito che si arresta giusto nell’attimo in cui si inocula in ciò che sarà sempre stato e non sarà mai, riuscendo a ‘fare il morto’ per non dovere entrare nel processo del divenire. Questo scarto sotto vuoto che si arresta, cristallizzato, proprio nell’istante celibatario che non può essere bloccato, è ciò che il lavoro video di Giovanni Oberti riesce a far vedere nonostante ciò che si mostra. L’artista enuclea lo spazio impossibile dì una ipostasi dello spessore plastico che sospende lo spazio sulla propria durata transitiva. Il video filma, come del resto denuncia fin dal titolo, lo iato che divide l’unione incompossibile dell’immagine con se stessa, tra lo spettatore e la superficie. Si viene così a mettere a fuoco l’inguardabile stesso, il frattempo aberrante che consiste fra l’arrivo dell’occhio e la partenza dell’oggetto al quale l’occhio ingiunge l’anamnesi di una flagranza, di una concomitanza, in questo caso il dipinto di Raffaello, ‘Lo sposalizio della Vergine’. il lavoro di Oberti, camera fissa davanti al dipinto, lungi dal non filmare nulla, filma nulla, esattamente Io spessore vacante che consiste in se stesso nella monotonia ‘dell’ora questo’ che si mostra attraverso l’aggrumarsi aptico in cui l’occhio fruga, alla ricerca della propria cecità. Filmare nulla qui significa approcciare l’istantaneità primigenia che si condensa in tutto ciò che non cesserà mai di durare, l’intervallo in diretta di ciò che non sorge, poiché (la) cosa che appare qui – ciò che ripetiamo, non può essere visto ma solo assecondato – non è stata ancora integralmente barrata, cancellata, rimossa dalla castrazione simbolica, ma sarà sempre stata qui, un passo prima che qualcosa sia ciò che è, esattamente nella schisi lamellare dove l’articolazione ‘gira a vuoto’, esponendo la visione al punto morto della sua pura enunciazione. Una visione, quella di Oberti, che si pone dunque come l’evento fondamentale sempre in corso; la visione di quanto è già qui e che non si riesce tuttavia a vedere. L’inconscio tattile come apertura protratta dell’istante senza riparazione che tarderà in eterno ad arrivare e che pertanto (non) si realizzerà mai. li ritardo, in questo lavoro, dice che è già lì, già da sempre convocato al proprio cospetto, e in ragione di questa sua presenza tarderà sempre, ancora e sempre di nuovo, ad arrivare. Si delinea in questo modo un atto finitamente formale, una stilizzazione ‘sterile’ che resta coagulata al di qua della propria incarnazione insistendo nel senza luogo del ‘proprio’ luogo differendosi sempre per l’ultima volta; ciò di sé si è già da sempre messo a finire senza alcuna possibilità di finire come peraltro di iniziare. Se come scrive efficacemente Jacques Derrida, “la differenza non è mai possibile in una sua supposta purezza”, allora non possiamo non convenire che ciò che qui ci interessa indagare è ciò che agisce ed interviene – in un quantomeno paradossale difetto dell’eccesso – all’interno del funzionamento di un qualsivoglia ‘precipitato segnico’ che non potrà mai non arrivare alla visione. E’ ciò che sembra ingenerarsi nel video di Ruth Scott, Lashing. Una ripresa ravvicinata testimonia il tentativo dell’artista di inscrivere un segno attraverso le proprie ciglia che, sfregando su di un foglio bianco, cercano di trattenere una traccia di grafite. Similmente a ciò che si può ravvisare in Oberti, si delinea qui una sorta di eviscerazione tattile dell’occhio che mima così il balbettare traumatico di ciò che già da sempre lo infesta clandestinamente facendone quasi un portatore sano di autismo sinestetico; ciò che la visione soffre senza saperlo o detto altrimenti, ciò che la visione sarà sempre stata nonostante la visione che sarà stata. Questo residuo a priori altro non è che l’apertura del luogo del suo luogo, il suo luogo potremmo dire immotivato in cui questo cul de sac tracima-al-suo-posto cristallizzandosi nel tel quel della propria impossibile comparizione ovvero in ciò che non è in quanto ‘esso stesso’. ll battimento attimale ed estimale dell’occhio incartato di Lashing, enuclea tautologicamente il fallimento costitutivo della presa in quanto accadimento, sincope e non essenza che, così facendo, altro non reitera che l’evento perpetuamente singolarizzato della propria esclusione che nasce proprio per non essere mai nata, liberando così l’implosione che certifica il fatto che se “c’è passaggio là dove l’antinomia si chiude, è perché c’era già prima della costituzione dell’antinomia stessa” (Lacan). Mutuando il ductus benjaminiano di dialettica in stato d’arresto si potrebbe arrivare a dire che questo topos senza posizione assume il parossismo dialettico proprio per sbarazzarsene una volta ‘per tutte…
Alessandro Sarri, Galleria Neon, Bologna, 2010